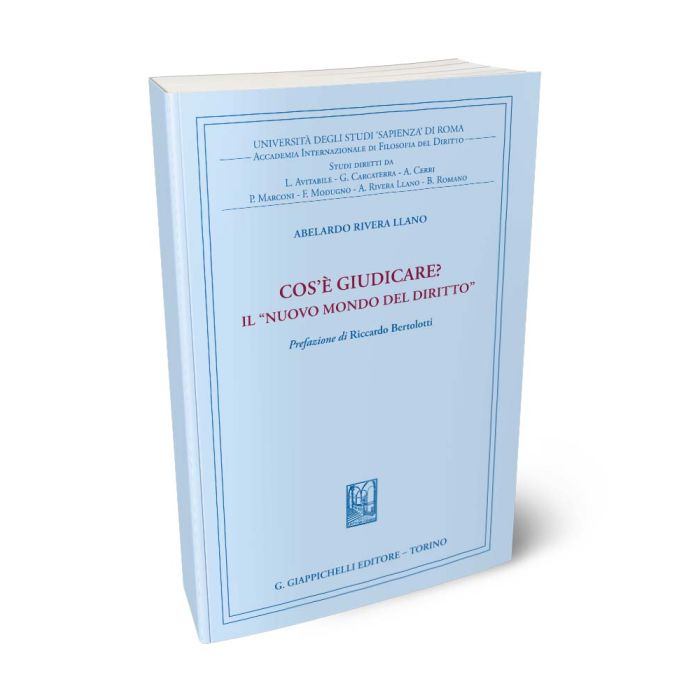Che cosa significa “giudicare”? Questa domanda percorre il lavoro di Abelardo Rivera Llano, che si snoda per capitoli densi di dialoghi a tutta pagina con i testi e rimandi agli autori toccando tutti i principali temi e motivi della riflessione giuridica contemporanea. Dall’insidiosa ricerca d...
Che cosa significa “giudicare”? Questa domanda percorre il lavoro di Abelardo Rivera Llano, che si snoda per capitoli densi di dialoghi a tutta pagina con i testi e rimandi agli autori toccando tutti i principali temi e motivi della riflessione giuridica contemporanea. Dall’insidiosa ricerca di un possibile orizzonte metodologico alla dissoluzione della soggettività (con l’ancor più arduo correlato dell’oggettività); dalla crisi (oramai permanente) del diritto positivo alla “trasvalutazione” dei tradizionali valori etico giuridici ad opera della forma di epistème (detto con Foucault) economicistica e tecnica; e di qui al conseguente deprezzamento della soggettività ultima della persona umana nell’orizzonte di un’utopica, compiuta artificialità dove il limite estremo da superare sia l’essere umano medesimo.
Ma “giudicare” è – se si considera la parola – un “dire” il diritto, ossia un momento, un’esperienza pratica di traduzione per mezzo della quale avvicinarsi al senso (sia esso inteso come un generico senso “giuridico” o, nello specifico, come senso “di giustizia”). Quindi, se la domanda sul giudicare implica (o per lo meno indica) una presa di posizione sul dire, allora il senso viene messo in questione. D’altra parte, mettere il senso in questione vuol dire in ogni caso riconoscere (o assumere) che il senso non sia (o non sia più) “pacifico”, che faccia problema, che entri in crisi.
Questo d’altra parte sembra lo sfondo di problemi sul quale si staglia da tempo quanto è stato chiamato la “neosofistica” contemporanea, il linguistic (poi semiotic) turn. Una prospettiva che nell’ambito giuridico venne tenuta presente in Italia fin dai primi anni Cinquanta, anche grazie all’opera di Bobbio e Scarpelli che operarono una vera e propria mediazione culturale tra l’orientamento allora prevalente qui, ancora caratterizzato dalla lezione gentiliana e crociana, e gli analitici statunitensi, eredi (già con profonde differenze) del logicismo viennese.
Venuta meno la possibilità dell’interrogazione ontologica ingenua, venuto quindi meno il “che cosa” come domanda rigorosa e con esso la possibilità di pensare seriamente la “sostanza”, si è costretti a volgersi a quelli che ne appaiono come i preliminari, le condizioni, ciò che gli sta prima e davanti. Ci si interroga allora non più sul quid, ma sul modo di dare senso a questa domanda, ossia sul progetto, sulla costruibilità e sull’impiego dello stesso enunciato. Ma lungo questo gioco di arretramenti tattici in cerca di una stabilizzazione (almeno in chiave metodologica) della domanda iniziale, tale stabilizzazione ovviamente sembra svanire come un miraggio tutte le volte che si crede di toccarla. Si finisce così con il porre in questione, più che la forma linguistica della domanda, la possibilità metalinguistica del domandare. Infine la stessa opportunità dell’“esperienza” interrogativa è revocata in forse.